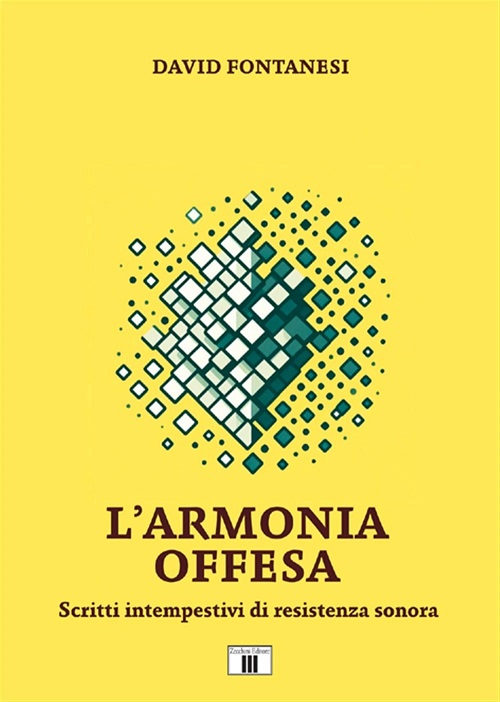
una cascata di invettive feroci e lucidissime firmate da David Fontanesi contro l'abbandono della forma, della frase, dell’idea nella musica del '900.
Kundera li chiamerebbe testamenti traditi. La cattedrale della grande musica smembrata, col beneficio di un’ideologica legittimazione, fatta a pezzi sotto i ferri di un anatomopatologo compiaciuto più del suo gesto estetico che della nobiltà del suo compito. Parole come lame arroventate, quelle che in “L’armonia offesa” David Fontanesi incide e comprime un libro tanto breve quanto caustico, dedicato alle macerie di una bellezza sfregiata fino a sfigurarne i tratti: la bellezza della forma, della frase, dell’idea.
Una musa oltraggiata, trafitta a morte dalle derive di un Novecento che, a suo dire, ha stravolto sintassi e ortografia della narrazione, sostituendo ad un giardino lussureggiante una serra di fiori di plastica, appesi a steli metallici. Diplomato in pianoforte e in composizione, cresciuto alle scuole di Lucia Lusvardi Gallico e di Azio Corghi, una laurea in filosofia medievale come contrafforte speculativo, Fontanesi fa di ogni pagina lo strumento per auscultare una materia che sotto il suo occhio impietoso viene spogliata di ogni artificio verbale, di ogni sovrastruttura, e scandagliata con viscerale, appassionata dedizione. Ciò che ne esce è una cascata di invettive feroci e lucidissime, destinate – intenzionate – a turbare e costringere all’angolo le nostre certezze. Sembrerebbe un’urgenza distruttiva, ma non lo è. Piuttosto, è la richiesta, urgente, frontale, ad aprire un dibattito sgombro da preconcetti e da ossequi.
Da battitore libero, Fontanesi sa come arrivare alla carne viva delle questioni, senza aggirarne i punti cruciali. Attraverso una galleria di accompagnamenti all’ascolto, contrappuntati da considerazioni e commenti, le pagine de “L’armonia offesa” percorrono, ora accarezzando ora fustigando, oltre un secolo di letteratura musicale, entrando nel merito delle scelte, degli esiti, e, con la smarginata libertà che solo il pieno disincanto può offrire, osano rompere il cerchio magico di commenti già scritti, aprioristicamente decisi. Un viaggio di resistenza sonora che accosta, tra di loro, mondi lontani poche decine di anni eppure appartenenti a galassie incommensurabili. Non è una questione temporale. Anche nel presente è possibile l’incanto di un ritrovato cosmos.
Con penna sempre densa, tesa, immaginifica, (che magnifico critico musicale sarebbe, capace, finalmente, di sottrarre alla restituzione verbale di un ascolto la patina unta e bisunta di frasi spesso cucite con filo grossolano da troppi apprendisti stregoni, intenti a commentare testi che non di rado nemmeno sanno decodificare!) Fontanesi attraversa spartiti e partiture, testi e sottotesti, sconfessando, smascherando, sbugiardando il banale sotto la pelle del ricercato e dell’intellettualistico. Ma, al tempo stesso, si sofferma di fronte all’incontro con la vertigine. Un passatista? Affatto. Non è una questione temporale; non è una posizione passatista. Anche nel presente è possibile l’incanto di un ritrovato cosmos. Il problema non è distinguere il vecchio dal nuovo, ci dice, ma l’autentico dal fasullo.
E se quasi intuitivi potrebbero essere gli ammirati tributi al Ravel della Sonatina (“Sabbia e cenere, nella polvere del clavicembalo”) e a Prokof’ev (la Sinfonia Classica, autentico galateo dell’abisso, tra sorriso e rovina), sorprendono quelli, catturati tra i battiti della contemporaneità, alla “Undine” di Henze, al lancinante “Stabat Mater” di Penderecki, al poetico “Concerto delle macchine” di Malipiero, all’estremo Šostakóvič del Quintetto per archi n°15, fino al commosso, toccante omaggio al Corghi, autentico, nobile faro di una perduta sapienzialità, di “Amor sacro, Amor profano”. Sull’altra riva, Fontanesi allinea, come miseri relitti di cui si sia accompagnato con lo sguardo l’inevitabile naufragio, le voci di Cage, Varèse, Donatoni, Schὂnberg, Boulez.
Un j’accuse di audace spessore – sebbene lui, in apertura, metta le mani avanti e dica di non voler spiegare né documentare niente - ma, soprattutto, un atto d’amore, un’entusiastica adesione, verso un ideale per cui, se necessario, impugnare le armi di una dialettica disposta ad un confronto all’utimo sangue. Sarebbe interessante aprire un dibattito, a partire dalle sue stesse parole. Ma per fare questo, occorre conoscere altrettanto bene il terreno del duello. Una lettura preziosa, coraggiosa, lontanissima, nell’anima, dalla sua ingannevole superficie di iraconda provocazione. Traboccante, invece, di spunti e di suggerimenti, di annotazioni di rara finezza. Anche se non se ne condividesse totalmente la posizione, leggerla e rileggerla renderebbe sicuramente più ricchi. E più consapevoli.